A cura di Dario Stazzone
Note sulla poesia di Salvo Basso
Ricordare l’intensa vicenda umana e intellettuale di Salvo Basso (Giarre, 23 ottobre 1963 – Scordia, 26 aprile 2002) è cosa ad un tempo piacevole e dolorosa. Piacevole perché permette di tornare alla forza della sua poesia, che in pochi anni si è affermata come una delle voci più originali della letteratura dialettale siciliana, a fianco di autori come Santo Calì e Nino De Vita. Dolorosa perché impone il ricordo della sua prematura scomparsa. 
Chi scrive ha conosciuto Basso. Rimangono indelebili i ricordi dei dibattiti pubblici con artisti, studiosi e intellettuali. Forte il ricordo della sua partecipazione al “Treno dei poeti” organizzato da Antonio Presti e Maria Attanasio. Difficile dimenticare poi alcune letture poetiche presso Villa Pacini a Catania: tra l’odore del mare e i più forti profluvi della pescheria, ho ascoltato Basso leggere le sue poesie con un ritmo peculiare e cadenzato, ho apprezzato la sua capacità di condivisione che ne faceva un punto di riferimento per altri giovani poeti.
Laureatosi in Filosofia presso l’Università di Catania con una tesi dedicata a Max Weber, Basso divenne nel 1994 assessore alla pubblica istruzione di Scordia e nel 1998 assommò a quella funzione la carica di vicesindaco.
I due aspetti apparentemente contraddittori, la creazione poetica e l’attività amministrativa, trovavano sintesi nella coerenza intellettuale del giovane assessore che avviò a Scordia un laboratorio letterario e poetico, coinvolse docenti e discenti delle scuole, realizzò un “Bookfestival” che, dalla prima edizione quasi ristretta ai locali dell’ex pescheria, divenne presto una realtà di respiro nazionale.
Era singolare vedere un comune del calatino trasformato in una “città d’utopia” dove si potesse parlare anche dell’universale umano immanente nella poesia, e non è casuale che tra le letture amate da Basso vi fossero i grandi utopisti del passato.
Anche l’affermazione di Basso poeta è avvenuta nel corso di pochi anni: dopo una serie di scritti in dialetto e italiano apparsi su diverse riviste, la prima silloge poetica, Quattru sbrizzi, venne pubblicata per i timbri Nadir nel 1997 (il libretto, divenuto introvabile, è stato recentemente riproposto dall’Arci Sicilia con prefazione di Anna Bucca e Domenico Simone). Segue un’originale riscrittura delle Ecclesiaste intitolata Quo, editata nel 1999 per le Edizioni dell’Obliquo. Sempre del ’99 è la raccolta Dui, arricchita da una prefazione di Manlio Sgalambro e una presentazione di Pietro Barcellona. Dopo la partecipazione al volume collettivo curato da Mario Grasso, Chiana e Bivieri, apparve purtroppo postumo Ccamaffari, con una prefazione di Franco Loi. Negli anni più recenti, grazie soprattutto alla cura appassionata di Renato Pennisi, sono stati pubblicati i versi inediti iniziando dal 1979: tra questi iuvenilia composti spesso in italiano si trova materiale prezioso per tracciare un ritratto dello scrittore da giovane e più ancora nuclei tematici che tornano con coerenza nella versificazione successiva. Appartengono a questo recupero i volumi Egomeio (Salvopoesie 1979-81), Libro necessario (poesie 1982-84), e Fase Lunare (poesie 1985-90).
Pochi autori come Basso hanno messo in evidenza, con forte coerenza diacronica e vocazione metaletteraria, la difficoltà della parola e della parola poetica in particolare: «Nun mancanu i pensieri. Mma i paroli ottròvili».
Allo sforzo del dire si accompagna spesso, nelle poesie, l’evidenza accordata al gestus corporis ed agli elementi metalinguistici che sono anch’essi anelito di significazione.
Basso è stato cantore dell’inutilità e dunque dell’assoluta necessità della poesia, ha creduto nella parola quanto più ne ha constatato la caduta e la consunzione, ne ha auspicato la resurrezione anche per viam negationis.
Paradigmatica della condizione dello scrittore è la silloge esordiale Quattro sbrizzi: una raccolta scandita in frammenti, versicoli e illuminazioni all’insegna della brevità. Come esergo al testo la prima poesia afferma: «è / ca si nun parru / ma sfighitìu». Consustanziale ai versi liminari è una riflessione sulla difficoltà odierna del poetare: «ma iu / nun sacciu mmintari / cchiù nnenti. / Prima / – poeta? – / pigghiavu, / a mmenti, / du paroli: / ncucchiavu, mi piaceva, / e ttaccavu na cosa. / Sa finevu / a finevu, / si nunna finevu / era bbona u stissu. / Di sti tempi / – pinsavu – / na poesia / nunnu sai mai / quannu finiscia, / quanna ffiniri». Il gusto della parodia intacca persino il motto «le parole sono pietre», per il quale non è da escludere una reminiscenza leviana (Basso fu lettore attento di Carlo Levi e Ignazio Buttita): «comu valunu picca / i paroli / ca finanmumentufà / pareunu petri, / ca mancu l’acqua / di ndiluviu cci putiva». L’ironia e la parodia investono con forza rovesciante persino proverbi ed espressioni idiomatiche: «a penna / è / un filu di capiddu»; «scrivu / picchì / mi mangiunu i manu»; «cchi / ccampu / a ddiri»
Se Basso è stato, a suo modo, cantore dell’impotentia loquendi et poetandi, occorre tornare agli esordi giovanili per trovare, nei versi italiani di Egomeio, l’archeologia tematica del poeta e l’espressione di una più ampia difficoltà esistenziale. Potrebbe sembrare stupefacente per chi è abituato alle poesia più nota di Basso imbattersi in un’opera evocativa del mito classico, il cui titolo tiene insieme per omoteleuto due termini in urto: Miope/Niobe. Nella lirica si legge: «A chi mi chiede / perché ogni tanto mi / tolgo gli occhiali per / stare seduto con la / bocca chiusa anche per / parecchie ore io / rispondo che lo faccio / per vedere la / realtà così come / vorrei vederla cioè / non vederla perché io / senza occhiali non / vedo niente. Buon / dio». Il tema autobiografico della miopia e degli occhiali, della distorsione del visus che non permette al soggetto poetante una adeguata visione della realtà o che si fa rifiuto della realtà stessa, determina isotopie semantiche presenti in tutta l’opera di Basso. La pietrificazione di Niobe, che secondo il mito classico assistette all’uccisione dei suoi figli per trasformarsi nella rupe del monte Sipilo stillante lacrime, è il rischio cui va incontro il poeta. Come la sofferente figlia di Tantalo che destò l’ira di Latona, così lo scrittore a rischio di pietrificazione denunzia la distonia tra l’uomo e il mondo, l’impossibilità di comunicazione col Tu affettivo, il tratto aleatorio della scrittura, persino le illusioni sottese dall’attivitàpolitica che si fa necessaria per absurdum. Si legge in Quattro sbrizzi: «si leva / l’ucchiali / e annorba: // u munnu / ora / cu sapi com’è», e nel postumo Ccamaffari: «Eru unu ca vuleva canciari / u munnu ma mancu iu mi / potti canciari…».
A ben leggere i suoi versi, sospesi tra dimensione patemica e ironia, Basso rimane un uomo del Novecento, dialetticamente anelante alla vita proprio mentre ne constata le difficoltà e le ineluttabili sofferenze. Non è un caso che oltre alla giovanile risemantizzazione del mito classico egli abbia realizzato una originale riscrittura delle Ecclesiaste.
Come si sa la suggestione del Quohelet connota l’intero Novecento poetico, da La terra desolata di Thomas S. Eliot in poi. Scrivendo il poemetto Quo Basso ha interpretato a suo modo la radicalità poetica del testo biblico che dichiara la vanitas vanitatum e che conferma la legge mosaica solo dopo aver lambito dialetticamente lo Sheol, ossia l’abisso delle domande senza risposta e della vita senza conoscenza.
In modo consustanziale al sentire del giovane poeta il verso lungo quoheletico si frammenta in versicoli che costringono a una lettura sillabata, faticosa e cadenzata, quasi a rappresentare nella forma la difficoltà di parola sempre denunziata dall’autore.
Lo stesso Quohelet è ridotto al monogramma o acronimo Quo, come se la scarnificazione della parola lasciasse sopravvivere di essa solo una traccia o un’eco appena allusiva. Franca Grisoni ha messo in evidenza che il dialetto di Basso, franto, forzato e sillabato, sembra qui dar vita a una peculiare ars combinatoria, quasi una cabalistica permutazione delle lettere: è così che dal siciliano emerge per anagramma la parola italiana «niente». Anche «nenti» e «nuddu» sono occorrenze ad alta frequenza in questi versi di notevole intensità patemica. «Nenti» è ripetuto più volte proprio ad incipit del poemetto per prolungarsi negli anagrammi successivi: «nenti // nenti // nenti // iente // iente // ientne», essendo l’ultima occorrenza allusiva e di «ente» e «niente».
La riflessione sulla sofferenza individuale e collettiva interseca i contenuti topici della Meghillat Qohelet e la sentenziosità del siciliano. Ogni aspetto della vita è passato in rassegna con disillusione, primo tra tutti il lavoro, connotato come stanca ripetizione anche dall’uso del complemento oggetto interno: «a cchi servi / tuttu / stu travagghiu / ca si travagghia / sutta / u suli/ ggenti / ca nasci / e mmori / a terra / sempriccà»; poi è la condanna delle parole false, rifiutate con indignazione dal poeta: «paroli / ca su / ttutti / fausi // nunni / vogghiu / nunn’aiu / ne sacciu»; la stessa conoscenza si fa portatrice di dolore: «ccu / cchiù / ssapi / cchiù / cci dola»; in un’ansia di cancellazione persino l’identità del poeta è investita d’ironia: «aiu / scrittu / libri / mi / maritai // macari / vicisinnnacu / aiu ddivintatu»; per gradatio ascendente si arriva alle affermazioni «iu mi spensu» e «nun sugnu»
Con Quo Basso ha dato voce nel modo più forte e intenso alla sua sofferenza: ci troviamo forse di fronte al centrum circuli della poesia del giovane autore, non scevra da movimenti di senso quasi impercettibili. Basso non rende del tutto monocorde il canto dell’arpa di Quohelet: nelle inquietudini che attraversano il poemetto di ispirazione biblica è rappresentata la comunanza del destino umano, «u / distino / è // u stissu / ppi tutti», mentre l’anelito di vita, contraddetto dalla più fosca delle previsioni, «(picchì) / moriri / prima / do tempu», riemerge nella dimensione sensoriale e nella particolare enfasi concordata alla visione: «ma mai / l’occhiu / è sazziu / di talari / ma mai / aricchia / di sentiri»; «megghiu / occhi / ca vidunu // paroli / assai / nenti»; «ma / mangia / viva […] // picchì / l’occhi / nunn’arriposanu /mai / nné / di iornu / nné / di notti»; «sulu / ccù ll’occhi / è a vita»
Anche se il poeta non affida solo a Quo la sapienza dolente della vita, in genere il movimento dialettico interno ai suoi versi, il filtro ironico ed autoironico, l’uso dei meccanismi parodici tribuiscono ad essi un diverso “tono” pur rimanendo eguali i nuclei semantici e contenutistici. Forse per questo Anna Montemagno si è spinta a parlare di «leggerezza» della poesia di Basso, precisando tuttavia, sulla scorta delle Lezioni americane di Calvino, che è compito del poeta contrapporsi alla «morsa di pietra» della vita come Perseo fece con Medusa. Basso ha ingaggiato una lotta con la Gorgone attraverso i versi dialettali dolenti e ricchi di significato. Perseo o Niobide che fosse, con una faticosa presa di parola, l’autore di Ccamaffari ha voluto sottrarsi al rischio cogente della pietrificazione.













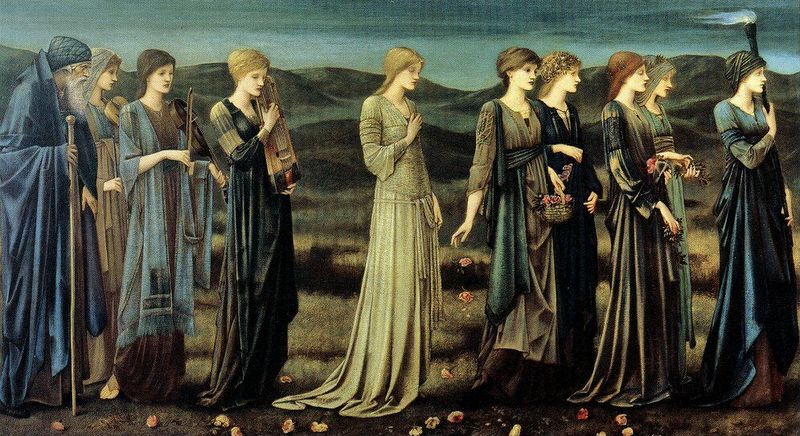





Social Profiles