A cura di Alfonso Sciacca
Il viaggio di Salvo e dei suoi amici (immaginari fino ad un certo punto), negli Stati Uniti e poi in America latina, fino al Perù, è una fuga in avanti, uno slancio verso sogni raggiunti in parte ma irraggiungibili e evanescenti nella maggior parte.

Un libro scritto per scherzo, forse, quello di Salvo Cavallaro (Date da mangiare ai pesci, Carthago, 2013): un libro che, alla fine, quando il lettore ha finito di leggere l’ultima pagina, finisce con l’assumere i panni di un libro serio, di quelli cioè che vanno dritti alla mente, prima che al cuore. E con grande sorpresa del lettore. Cavallaro è un giovane avvocato: esercita l’attività forense da qualche anno, e vi si dedica professionalmente. La sua vocazione, che cova stabilmente nel fondo del suo animo pronta a risalire in superficie per far sentire l’urgenza e la necessità di essere soddisfatta, è la scrittura. Il leggere e lo scrivere insieme: che sono due attività complementari, nel senso però che si può essere accaniti lettori, e non essere portati alla scrittura; ma non viceversa. Non si può essere bravi scrittori senza sentire il bisogno di leggere e di confrontarsi con la scrittura degli altri. Cavallaro appartiene a questa seconda categoria. Leggendo questo suo libro ne rileviamo la prova provata.
Si tratta di un libro di racconti, non molti, ma rappresentativi della personalità dello scrittore. Quasi tutti brevi, tranne il primo che dà il titolo all’intera raccolta. Sono tutti accomunati da un filo conduttore che li attraversa lievemente, quasi sotto traccia. Benché ancora giovane, questo scrittore sente la levità dell’esistenza umana. Può infatti accadere che uno scrittore si immerga a tal punto nella trama dei fatti narrati da non riuscire a dominarli: le redini del racconto gli sono usciti di mano, e lui, il narratore, non riesce più a governarli, a condurli, a reggerne la forma e la sostanza. Dall’altra sponda, il lettore sente anch’egli una pesantezza angosciante dinanzi alla pagina che non lo lascia assolutamente respirare. Leggere e scrivere sono una fatica. Tutto ciò non si può dire per Cavallaro che scrive levitando dolcemente sulla realtà, guardandola con un sorriso di tenerezza e di compiacimento. Direi anche con un sorriso di complicità. Ed è questa la sua dote migliore: la complicità con la scrittura, nel senso che, se la scrittura è trascrizione non sempre fedele della realtà, al punto tale che essa riesce a modificarla, questa realtà, trasgredendo le solide regole della mimesis aristotelica, egli, Cavallaro, è ben cosciente di questo atteggiamento trasgressivo, se ne compiace, e lo cavalca. Il risultato complessivo e finale è quello dell’ironia.
C’è un archetipo nel romanzo di Cavallaro: il famosissimo Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome (1889), dove è descritto un viaggio in barca lungo il Tamigi, pieno di gag e di imprevisti. Non importa che Salvo l’abbia letto, e che la sua memoria gli sia rimasta impressa nella mente. Ma l’archetipo, a mio giudizio, è proprio questo. Il viaggio di Salvo e dei suoi amici (immaginari fino ad un certo punto), negli Stati Uniti e poi in America latina, fino al Perù, è una fuga in avanti, uno slancio verso sogni raggiunti in parte ma irraggiungibili e evanescenti nella maggior parte. È questa maggior parte del sogno è l’altra parte della vita: quella che non si è vissuta e che mai si potrà vivere. Ciò non porta sgomento; non frastorna e non tormenta l’animo dell’autore, grazie alla leggerezza della scrittura. La scrittura di Salvo ritempra e ricrea, asseconda l’autore nel racconto del fantasioso, gli mostra l’altra parte della luna, quella che noi uomini siamo costretti a non vedere mai. Tranne che chiudendo gli occhi cerchiamo di immaginarcela e di trascriverla sul foglio bianco della nostra invenzione poetica. Non a caso ho parlato di luna: uno di questi racconti ha come protagonista un astronauta, e rappresentativamente realizza i sogni irraggiungibili del nostro autore.
L’altro archetipo è Italo Calvino, una delle voci più autentiche del nostro Novecento. Alla “leggerezza” della scrittura è dedicata una parte cospicua della sue “lezioni americane”. L’ultimo racconto è, a mio giudizio, il più toccante. Il volo del calabrone segna un progressivo e faticoso andare dalla “immaginazione” alla “condivisione”. La verità delle cose (quella verità che ci resta in buona parte nascosta e misteriosa) si rivela solo nel momento della condivisione. Possiamo tenercela per noi, la verità. Ma che ce ne facciamo di una verità solo ed esclusivamente nostra? Finirà, con il passare del tempo, che questa verità si illanguidisca, svanisca perdendo ogni giorno una parte di se stessa. La verità ha bisogno di essere condivisa, partecipata. Ma non sempre questo ci riesce facile: perché la verità fa male. Nella novella si ha un lieto fine, che, in fondo, è il messaggio finale e conclusivo che l’autore vuole lasciarci. Il primo racconto era sferzante, icastico, perfino doloroso. Era un viaggio impossibile verso l’amore. Un amore totalizzante. Un amore condiviso. L’ultimo racconto ha un tono più positivo.
Non resta che complimentarci con l’autore, in attesa di ulteriori conferme della sua vena narrativa.













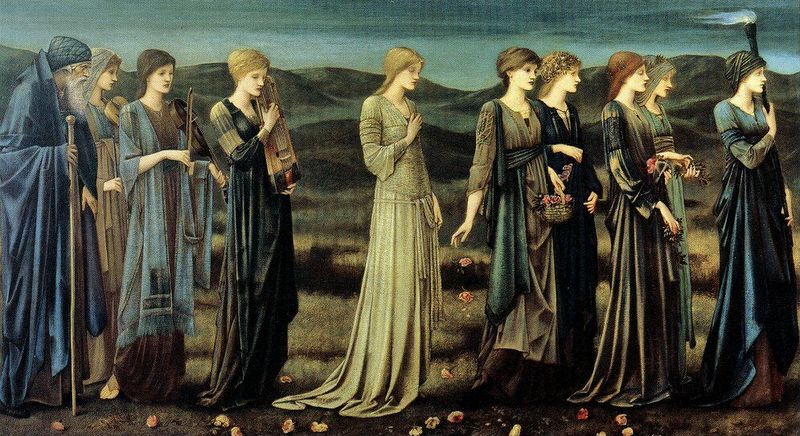





Social Profiles